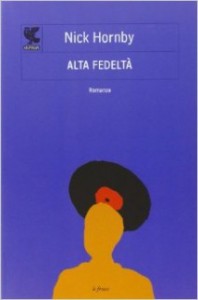Amara, divertente e commovente.
Questa è una storia d’amore e di musica. Di “alta fedeltà”: quella dei dischi, si, ma anche quella, ben più complicata, delle storie d’amore.
Rob Fleming ha 35 anni, un negozio di dischi fallimentare ed è appena stato lasciato. Di nuovo, e di nuovo non capisce perché.
In sicuro e burbero, rintanato nel suo negozio nel nord londinese si arrovella su quesiti del tipo : “sono triste perché ascolto canzoni su cuori infranti oppure ho il cuore infranto perché ascolto musica triste? Cosa viene prima, la musica o il cuore infranto?”. Rob ha il pregio di essere straordinariamente divertente nei suoi tentativi, imbranati, di dipanare la matassa emotiva.
È un personaggio che non riesce a stare al centro del suo mondo…e qui sta il bello: sbanda continuamente e ci trascina con sé in una Londra vibrante, costellata da trentenni sognatori, al ritmo di tutta quella musica, nominata, citata, menzionata, che scandisce a meraviglia il ritmo del racconto (ho avuto la tentazione di tenere aperto youtube ogni volta che saltava fuori un titolo, ma le disavvenutre di Rob mi prendevano troppo per poterlo fare con calma).
Nick Hornby ha creato un libro scanzonato, diventato cult per i giovani degli anni ’90. Per quella “generazione X” un po’ sbandata, che magari, come Rob, ha lasciato l’università ed è rimasta al palo per non aver saputo – o voluto – scegliere una strada, sia emotivamente, sia professionalmente. Per paura di diventare qualcosa di definito.
Non a caso, i personaggi – specialmente uomini – non scelgono mai veramente nulla. Quello che fanno, invece, è stilare liste: le cinque migliori canzoni n.1 / lato A, le cinque più grandi fregature amorose, i cinque lavori da sogno che avrei voluto fare…
Le donne, invece, sono dipinte come un centro di gravità, per quanto misterioso.
Questo è un libro creato per relativizzare un ideale romantico e giovanile, un po’ autolesionista, e non avere più paura. E, perché no, anche per ascoltare (nuova) musica.